|
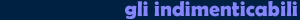

I
piu' applauditi in maglia azzurra
|
 |
Sallustro, il primo
mito napoletano
Prima
"stella" del Napoli dalla fondazione, 1926, fino al 1937, primo mito del calcio
napoletano nello squadrone di Garbutt. Nato ad Asuncion , ma da
genitori italiani, giocò in azzurro (esordio poco più che
diciassettenne) 262 partite, segnando 107 gol.
Il “veltro” fu chiamato in nazionale – in rivalità con - Meazza -
l’1-12 1929 contro il Portogallo, segnando una rete. Anche come
riparazione per le preferenze della nazionale verso il “balilla” Meazza, il Napoli regalò al dilettante Sallustro una fiammante auto
Balilla, dal valore di novemila lire. Ma era anche il periodo nel
quale Sallustro giocava gratis.... Accomunava scatto felino e potenza di tiro. A volte il
carattere ne condizionò il rendimento. Corteggiatissimo dalle donne, considerato un Rodolfo
Valentino del calcio, si invaghì e sposò una bellissima soubrette,
Lucy D’Albert . Restò a lungo nell’orbita del Napoli, chiamato anche
come tecnico “salvatutto” (nel 1960-61 al posto di Amadei) e poi come direttore
del "San
Paolo". Morì nel 1983. Invano si è tentato di intestargli lo Stadio
San Paolo, come Milano fece con il suo Meazza.
|
 |
Vojak,
per il Fascismo si chiamava Vogliani
La mezzala destra Antonio Vojak, un altro indimenticato
protagonista del grande Napoli degli Anni Trenta, fu acquistato da Ascarelli, sotto la guida di mister Garbutt, nel campionato 1929-30,
prelevato dalla Juventus. Insieme con Vojak vennero ingaggiati, il
portiere Cavanna dal Vercelli (zio di Piola), il terzino Vincenzi
dal Torino,la mezzala sinistra Mihalic dalla Fiumana e l’ala destra
Perani dall’Atalanta, ovvero il nucleo centrale che – insieme con
Innocenti, De Martino, Roggia, Buscaglia e Fenili – costituì lo
squadrone di mister Garbutt. In quei sei campionati in azzurro Vojak
collezionò 189 presenze , segnando 103 gol, appena sei meno del
goleador Sallustro. Giocò anche in Nazionale A e B. Il Fascismo,
nell’assurda lotta ai cognomi stranieri, gli impose di chiamarsi
Vogliani. Dopo l'esperienza napoletana si trasferì al Genoa e
concluse la carriera nella Lucchese. Tornò a Napoli come
allenatore nel 1940 (due stagioni e mezza, sostituito da Innocenti)
|
 |
Colombari, 'o
Banco 'e Napule
Enrico Colombari, un altro giocatore simbolo del Napoli di Garbutt, il mister che parlava poco e fumava molto. Ma l’allenatore
inglese si impose con la sua parola sull’allora presidente Giovanni Maresca
di Serracapriola convincendolo e costringendolo ad acquistare per la stagione
1930-31, insieme con l’ala sinistra Tansini (dal Milan) e il terzino
Castello (da Genova), Enrico Colombari, già autentico asso del
nostro calcio, centro sostegno e laterale ambidestro del Torino. Il
neo acquisto azzurro fu subito soprannominato “quarto di milione”, oppure
" ‘o Banco ‘e Napule”
perché da solo era costato la cifra-record di 250 mila lire. Il
trasferimento destò molto scalpore in Italia. Quando
Colombari cadeva sul campo, l'immancabile buontempone esclamava: “E’ caduto ‘o Banco ‘e Napule”. Con il
suo gioco illuminato e costante risultò molto utile allo squadrone
di Garbutt. Colombari Giocò, in 7 stagioni, 213 partite in azzurro. Nove
presenze in Nazionale. Concluse la carriera a Pisa.
|
 |
Amadei,
"grande amore" con Lauro
Amadei fu il
primo fuoriclasse del dopoguerra napoletano. Centravanti della
Nazionale e dell'Inter, il “fornaretto” (lavorava come garzone di
panettiere nella natia Frascati) ventinovenne fu acquistato, insieme con
Remondini e Casari, altri due giocatori reduci dai mondiali in
Brasile. Tutti
voluti e cercati dal presidente Musollino, pochi mesi prima di
morire a 43 anni per un infarto davanti all’incendio del Ristorante
D’Angelo. Amadei ricco di esperienza, di astuzia, di classe, meritò
l’appellativo che gli avevano dato nella Capitale come “ottavo re di
Roma”. Dopo le sette presenze in nazionale con la maglia dell’Inter
ne aggiunse altre sette con quella del Napoli. Bella l’intesa con
Jeppson e Pesaola. Non altrettanto proficuo il rapporto con lo
stesso “petisso” e con Vinicio quando fu allenatore azzurro. D’amore
e d’accordo invece con Lauro. Giocò in azzurro dal 1950 al 1956,
con 171 presenze e 47 gol. A 22 anni , nel 1943, da giallorosso - dopo aver vinto uno scudetto - fu squalificato a
vita e poi amnistiato, a guerra finita, per un pugno sferrato
all'arbitro Pizziolo.
|
 |
Vinjei,
costretto a cambiare nome
Moltissimi
giovani tifosi d’oggi non lo conoscono nemmeno per sentito dire.
Eppure Vinjei può figurare anche in una formazione ideale del Napoli di
tutti i tempi. Indomabile e mobilissimo terzino di origine
ungherese, ambidestro, poliedrico (tanto da essere impiegato una
volta anche come centravanti e sovente fu utilizzato come prima
interpretazione del “libero” , un ruolo per il quale sembrava
tagliato), Vinjei fu il punto di forza di quel Napoli di Monzeglio,
chiamato a fare la guardia – al fianco dell’altro coriaceo terzino
Comaschi – a Casari e a Bugatti e a lanciare Jeppson, Amadei,
Pesaola. Era dotato anche di un tiro proibitivo. Proveniva dal Sokol Koosice,
una squadra cecoslovacca, ma per essere tesserato l'ungherese
Vinjei, dopo lo sconfinamento, fu costretto in Cecoslovacchia a cambiare nome e
diventò Vincenc Prosovsky. Quindi andò alla Pro Patria e
arrivò poi al Napoli già ventinovenne, giocando con la squadra partenopea dal 1951-52 al 1954-55. A 33 anni passò alla Spal per
riscatto della lista, dopo 114 presenze in azzurro. Un campione che
lasciò il segno.
|
 |
Jeppson, molte scintille con
Monzeglio
Dopo
Colombari, ecco la seconda “bomba” napoletana sul mercato: Hasse
Jeppson centravanti della nazionale svedese ai mondiali del 1950 e
successivamente dell’Atalanta. Passò al Napoli – colpo di Lauro –
nel 1952, per 105 milioni, un record allora, dei quali 70 all’Atalanta
e 35 al giocatore versati in valuta aurea in Svizzera. Per la prima
volta un giocatore era venuto a costare più di 100 milioni! Da
considerare che nel 1952 il bilancio annuale del Banco di Napoli fu
di 500 milioni. Alto un metro
e 80, amante di musica, giocatore di tennis, intelligente e freddo,
un vero centravanti di sfondamento all’antica, dopo Sallustro. Di
grande onestà professionale. Ereditò da Colombari l’appellativo di
“Banco ‘e Napule”. Sul campo andò soprattutto d’accordo con Amadei,
fuori campo le scintille furono con Monzeglio e con Lauro. Restò
quattro stagioni, di cui una non fortunata in coppia con Vinicio, suo
successore. 112 presenze in azzurro, 52 gol. Alla fine, lo accusarono di abulia
e fu anche vittima di infortuni a catena (tra cui un gravissimo incidente stradale
in cui morì il suo autista) che
ne limitarono il rendimento. Tra polemiche,
battibecchi, incomprensioni con la società, venne ceduto al Torino con
lista gratuita.
|
 |
Vinicio, un idolo dopo
solo 40 secondi
Dopo Sallustro e
Jeppson, arrivò a Napoli, nel 1955, il terzo bomber di razza, Louis
Vinicio De Menezes, 23 anni, centravanti brasiliano del Botafogo. Il
Napoli senza fortuna tentò di farlo passare per oriundo. Si
presentò al Vomero, alla prima giornata, con un gol favoloso al
Torino dopo appena 40 secondi (nella foto), lasciando presagire
un’accoppiata d’oro con Jeppson, il che purtroppo non avvenne e dopo
un anno il tandem si sciolse. Attaccante di grande determinazione,
un ariete coraggioso, più volte restò in campo e segnò pur essendo
menomato da infortuni. Fu chiamato suggestivamente "'o lione". Giocò nel Napoli 5 stagioni (152 presenze e 70 gol). Destino di centravanti. Anche
Vinicio, come Jeppson, lasciò Napoli dopo una fase nerissima,
persino boicottato all’interno. Con Amadei e il suo clan non poteva
restare. Venne fuori una strana storia di globuli rossi, poi
smentita. Ritenuto ormai senza forze, sulla soglia della trentina, fu svenduto al Bologna, praticamente
regalato. Ma non era finito. Quando poi ( con la cittadinanza
italiana) passò al Vicenza, a 34 anni abbondanti, si aggiudicò la classifica dei
cannonieri con 25 gol,
tre al Napoli!
|
 |
Pesaola, fuga, dribbling e cross
per Louis
Oltre
che per i suoi brillanti successi come allenatore del Napoli (due
promozioni in A e tre Coppe), Bruno Pesaola è ricordato anche per il suo lungo
periodo di militanza in maglia azzurra. 240 partite, 27 gol, in un periodo che
va dal 1952 al 1960. Attaccante poliedrico, piccolo e veloce, il
petisso (che vuol dire appunto "piccolo") era abile soprattutto quando
agiva da ala sinistra: fuga, dribbling e cross per servire Jeppson e
poi Vinicio. La Roma lo prese dal River Plate, poi lungo stop per la
frattura di tibia, perone e malleolo. Stava per tornare in Argentina
quando Piola lo chiamò a Novara. Andò bene e passò
successivamente al Napoli
per 30 milioni. E qui offrì il meglio di sè. Arrivò nel Golfo in viaggio di nozze con la
bellissima moglie Ornella, miss Novara. Dopo 8 anni di Napoli,
trentacinquenne, chiuse la carriera di giocatore a Genova. Come
Vinicio, non sopportava più mister Amadei e perse il braccio di
ferro. Durante l'esperienza napoletana fece anche il suo debutto in
Nazionale a Lisbona, Dopo le successive esperienze da allenatore, è diventato
napoletano a tutti gli effetti.
|
 |
Juliano e
il Nord, non sopportava i
detrattori
Totonno Juliano,
portabandiera del calcio partenopeo, per ben sedici stagioni con la
maglia azzurra, l’unico esempio di giocatore, nato,
cresciuto e impostosi a Napoli, tanto bravo da raggiungere una vera
dimensione nazionale. Cominciò in sordina, debuttando a vent’anni in
Serie A nel campionato 1962-63 (con retrocessione) contro l’Inter al
San Paolo. Una sola presenza. Ma dal campionato successivo, in Serie
B, cominciò la scalata verso quel ruolo, regista-cursore, che lo vide brillante e
decisivo partner soprattutto di Sivori, Altafini e Canè, in un
Napoli tra l’altro secondo, terzo, quinto in classifica. Per alcuni
anni, grande temperamento e dinamismo, fu anche uno dei cardini della
Nazionale, 18 presenze dal debutto nel 1966. Napoletano di
estrema sensibilità, notava nei suoi frequentissimi contatti - e ce lo
confessò amaramente, facendo nomi e cognomi - una certa "puzza sotto
il naso" da parte dell'ambiente calcistico settentrionale nei
confronti dei meridionali, come lui. Nei sedici
campionati con il Napoli collezionò ben 394 presenze e 38 gol. Passò
al Bologna. Da dirigente fu impegnato più volte. Decisivo il suo
contributo per l’acquisto di Maradona.
|
 |
Sivori, genio,
fantasia e ...vendette
Nel Napoli di Fiore
(e Lauro) neopromosso in A nel 1965, arrivò anche Sivori, genio
argentino di cui la Juve doveva disfarsi perché Omar era in rotta con
l’allenatore Heriberto Herrera, il quale pretendeva che Sivori si
allenasse e sgobbasse nelle partite. Valutato 300
milioni, stava per essere dirottato a Varese, ma intervenne Lauro presso Agnelli, commissionando motori Fiat per due sue
nuove navi , ottenendo così anche di pagare in due anni i milioni scesi a novanta. Fu un grosso colpo, salutato al suo arrivo
alla stazione di Mergellina da 10mila tifosi i.
Esultanza che si trasferì poi sul campo dove Sivori mostrò di essere
ancora un campione, al fianco di Josè e Juliano.
Inimitabile il suo repertorio di finte, dribbling e tunnel.
Linguacciuto e vendicativo in campo (da ricordare la sfida e gli
screzi con Heriberto al S.Paolo: si inginocchiò davanti alla sua
panchina per allacciarsi le scarpe e per recitargli "Jijo de puta") nei suoi 12 anni italiani
totalizzò ben 33 turni di squalifica. Giocò
fino al 1969: 61 presenze, 12 gol. Fu però deludente nell’ultima
stagione, non reggeva agli allenamenti, indisciplinato, squalificato
per 6 giornate, tornò in Argentina a 33 anni.
|
 |
Altafini,
da "coniglio" a "core 'ngrato"
Nel
Napoli neopromosso del 1965 il nome di Altafini è collegato con quello di
Sivori, la coppia-regina che fece grande il Napoli di Fiore in quel
periodo. Altafini (già nazionale) fu acquistato per 300 milioni dal Milan in cui ormai era “indesiderato” dopo aver provocato con i suoi
atteggiamenti la perdita di uno scudetto quasi vinto e finito poi
all’Inter. Il presidente Felice Riva preferì cederlo al Napoli
e non alla Juve. Indimenticabile l’accoglienza dei tifosi
sulla pista di Capodichino. Con le magie di Sivori, la classe di
Josè, i gol di Canè, la regia di Juliano quel Napoli guidato da
Pesaola arrivò terzo, riconquistando il prestigio di un tempo. Era
dall'epoca di Garbutt, 32 anni prima, che il Napoli non finiva terzo!
L’Inter vinse con appena 5 punti in più. In sette stagioni il brasiliano
giocò 179 partite in azzurro e segnò 97 gol. Poi passò alla Juve e
segnò quel famoso gol che stroncò le speranze per lo scudetto del
Napoli nel 1975 (secondo posto a 2 punti dalla Juve) e gli valse il
titolo di "core 'ngrato", dopo quello (ingiusto) di
"coniglio", appioppatogli quando era al Milan.
|
 |
Zoff fu quasi
regalato alla Juventus
Dino Zoff, razza
friulana, di poche parole, freddo con un innato senso della
posizione, esemplare nei comportamenti, erede dei grandi portieri che avevano vestito la maglia del
Napoli (Cavanna, Casari, Bugatti) fu un pregevole colpo (forse l’unico)
di Giacchino Lauro, il figlio del Comandante che nel 1967 venne imposto
dal padre alla guida degli azzurri, a danno di Roberto Fiore. Ma
Lauro dopo aver dato il giocattolino al già interdetto Gioacchino,
glie lo tolse, di fronte ai guai e ai debiti del presidente-meteora.
Zoff fu un grande, impareggiabile protagonista durante le sue cinque
stagioni partenopee (con un secondo e un terzo posto), disputando
ben 143 partite. Al termine del campionato 1971-72, Zoff fu
inopinatamente svenduto alla Juve di Allodi. Era il portiere della Nazionale
già con 19 presenze! In cambio arrivarono dalla Juve il portiere
Carmignani e il centravanti misterioso Ferradini. Il più grosso
errore nella storia del Napoli. Comunque, è stato proprio con la
Juve che Dino Zoff ha poi raccolto i più significativi successi
della sua splendida carriera. In maglia juventina, fu protagonista,
insieme con Altafini (gol in extremis) della famosa e
indimenticata vittoria bianconera che impedì al Napoli di vincere lo
scudetto nel 1975. Se non lo avessimo ceduto alla Juve, chissà...
|
 |
Savoldi, sotterfugio di Ferlaino
per il contratto
Fu il primo
grosso colpo di mercato di Ferlaino. Nel 1975, dopo un secondo
posto, per vincere lo scudetto strappò il capocannoniere al Bologna,
con una rocambolesca trattativa. Ottenuto il contratto – in maniera
…scherzosa, si giustificò poi il presidente emiliano – Ferlaino lo depositò
nella cassaforte dell’albergo in una busta intestata al D.T. Janich
“nel caso mi capitasse qualcosa”. E infatti al “Principe e Savoia”
ritornò il presidente del Bologna, Conti, pentito e con
una pistola. Minacciò Ferlaino,
impaurito, disse di essere prigioniero dei tifosi che volevano
persino ammazzarlo, strappò una piccola promessa che Ferlaino
ovviamente non mantenne. 28 anni, arrivò per la cifra record,
evento storico, di due
miliardi (in cambio di Clerici, la comproprietà di Rampanti e 1400
milioni). Napoli città povera, in Italia si gridò allo scandalo
e agli sprechi.
Come se fossero stati soldi della comunità. Ma Savoldi pur
impegnandosi, ma male assistito, non fu sempre all’altezza delle
aspettative dei tifosi, molto esigenti per quel "pezzo da novanta". Solo 4 stagioni, 118 presenze (tante), 77 gol, di cui
55 in campionato. Tornò al Bologna. Ha avuto poca fortuna in Nazionale: solo quattro partite. E' rimasto legato a
Napoli.
|
 |
Ferrara, lo stesso
bilancio di Diego
Uno dei più grandi
difensori del Napoli, forse il migliore. Napoletano verace, Ciro
Ferrara, nato nel 1967, arrivò
al Napoli appena sedicenne (2 milioni in costo), vinse il campionato
allievi nel 1983-84 ed esordì in Serie A la stagione successiva,
proprio contro la Juve, come Cannavaro. Agile, grintoso, abile
colpitore di testa, in dieci stagioni (247 presenze, 12 gol) ha
vinto col Napoli due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa
italiana, e una Coppa Uefa. In pratica lo stesso straordinario
bilancio di Maradona col quale condivise i trionfi azzurri. Nel 1994
il passaggio alla Juve. Con i soldi della sua cessione, il Napoli
raddrizzò il bilancio, come avveniva spesso in quegli anni di
depauperamento, con la vendita dei migliori giocatori. Altri dieci anni nella Juve, con nuovi trionfi e presenze in
Nazionale, per poi diventare
dirigente-tecnico in maglia bianconera e nella Nazionale campione
del mondo in Germania a fianco di Lippi. Una carriera
lunghissima, favolosa, irripetibile, un grosso orgoglio
per Napoli tutta.
|
 |
Maradona, un trucco
per acquistarlo
Il più grande, il
più amato, un genio del calcio. Irripetibile, autentico
uomo-squadra, nonostante i suoi
problemi personali che ne hanno accorciato la carriera, hanno
aumentato il rimpianto, ma non incrinato il ricordo e l’affetto dei
tifosi. Cresciuto nei quartieri poveri argentini, quando il Napoli
lo acquistò dal Barcellona nel 1984 era già “il migliore”, 24 anni,
ricco, con la sua “corte”, i primi trionfi e le prime “debolezze”,
diciamo così. Per il suo ingaggio fu protagonista -testardo Juliano, ma ci vollero vari colpi di genio di Ferlaino per
strapparlo al Barcellona, per reperire i 13 miliardi, per dribblare
i regolamenti (una busta vuota in Federazione sostituita nella notte
dopo la firma di Diego) e per convincere Diego a restare qualche
anno in più a Napoli. Al suo arrivo un S. Paolo zeppo (a pagamento) solo per
vederlo palleggiare. Con gli uomini giusti al suo fianco arrivarono
2 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa Uefa. Poi
la malinconica e prematura fine, nel ’91, dopo una squalifica per doping (15 mesi) e dopo
sette anni magnifici e terribili in maglia azzurra. 188 presenze e 115 gol, di cui 81
in campionato.
|
 |
Careca, "tira la
bomba, tira la bomba!"
Il secondo scudetto
del Napoli, nel 1989-90, una Coppa Uefa e due secondi posti. Ecco il bilancio di
Antonio Careca nei suoi primi tre anni in maglia azzurra. Quasi un record.
Arrivò nel 1987 dal Sao Paulo per aumentare la potenza offensiva del
Napoli che l’anno prima aveva pur vinto lo scudetto. E Antonio Filho
De Oliveira, detto Careca, brasiliano di Araracquara, coetaneo di
Maradona, già nazionale, centravanti agile e di grande potenza, fu
un punto di forza di quel Napoli, protagonista di tanti successi,
con un’intesa esaltante con Maradona, una coppia indimenticabile, in
campionato e in Coppa Uefa e successivamente con il “gioiellino”
Zola. che si impose definitivamente all'attenzione. “Carè, Carè, Carè, tira la bomba, tira la bomba” cantavano
i tifosi azzurri dalle curve e il brasiliano segnò 96 gol nella sua carriera azzurra
(di cui 73 in campionato). con 166 presenze . Nel 1993 Careca tornò in
Brasile, ma ha avuto frequenti contatti con l'ambiente del tifo
napoletano, offrendosi anche come segnalatore (inascoltato) di talenti brasiliani.
|
 |
Cannavaro, da
raccattapalle a mondiale
Ha conquistato la
sua maturità lontano da Napoli , con lo splendido sigillo mondiale,
ma Fabio è stato un giocatore indimenticabile anche per quanto ha
fatto a Napoli, nelle tre stagioni che hanno preceduto il suo
trasferimento al Parma, per far quadrare i soliti conti in rosso di Ferlaino. Merita,
quindi, di figurare in questa collana, lui capitano indomito,
napoletano verace, campione del mondo. Figlio d'arte, a 11 anni entrò nelle
giovanili del Napoli. Fu acquistato da Rosario Rivellino, insieme
con altri due ragazzi, tra cui Caruso e Ametrano, dall'talsider in
cambio di un biliardo (4 milioni e mezzo). Raccattapalle al S. Paolo ai tempi di Maradona,
prese a modello Ferrara. Marcava Diego in allenamento. Esordì a 20 anni
contro la Juve nel ’92-93 e conquistò la riconferma per altre due
stagioni, subito beniamino dei tifosi per il suo carattere leale, da
moderno guerriero. Dopo 58 presenze in azzurro, passò al Parma (8
stagioni), poi all’Inter (3), alla Juve (2), infine al Real Madrid
da campione del mondo. Pallone d'oro 2006, il prestigioso trofeo di
France Football, dopo Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982),
Roberto Baggio (1993), quindi primo napoletano nella storia. Ha
vinto anche il titolo di "calciatore dell'anno" 2006, davanti a
Zidane.
|
|
Diego, il Profeta che prometteva gloria
di Massimo Corcione
 Meno
male che l’hanno ritirata quella maglia numero 10. Per
almeno due generazioni di calciatori passati per Napoli
ha pesato come un macigno. L’ultimo a indossarla fu
Roberto Sosa nella giornata della festa per un
campionato di C1 che i tifosi napoletani hanno già
sistemato nell’angolo più remoto della memoria. Lo
chiese più per devozione che per convinzione: lui,
argentino, aveva una voglia pazza di possedere una cosa
in comune con l’Idolo della sua infanzia. Che poi è
stato l’idolo di una nazione, l’Argentina, ma
soprattutto l’idolo di una città, Napoli.
Meno
male che l’hanno ritirata quella maglia numero 10. Per
almeno due generazioni di calciatori passati per Napoli
ha pesato come un macigno. L’ultimo a indossarla fu
Roberto Sosa nella giornata della festa per un
campionato di C1 che i tifosi napoletani hanno già
sistemato nell’angolo più remoto della memoria. Lo
chiese più per devozione che per convinzione: lui,
argentino, aveva una voglia pazza di possedere una cosa
in comune con l’Idolo della sua infanzia. Che poi è
stato l’idolo di una nazione, l’Argentina, ma
soprattutto l’idolo di una città, Napoli.
Forse mai l’immedesimazione in un campione è stata
tanto completa. Per sette anni Maradona è stato Napoli,
anche se non era nato a Mergellina e neppure nelle Vele
di Scampia. Più di quanto non fosse già accaduto per
Attila Sallustro, più di quanto non fosse riuscito a
Luis Vinicio che pure vide le proprie nozze benedette da
migliaia di napoletani, in Piazza del Plebiscito.
Nessuno più di Maradona ha interpretato le
contraddizioni della capitale
 dell’eccesso,
fino alla rovinosa caduta dall’altare nella polvere. Il
santino di Diego è tornato presto lassù per essere
adorato anche da chi non ha mai avuto la fortuna di
vederlo giocare dal vivo. Il miracolo laico di Maradona
è proprio qui: attraversa le classi, le generazioni, le
nazioni, fino a unificare nel suo nome il mondo intero.
Da qualche anno nessuno o quasi propone più quell’insopportabile
quesito al quale i napoletani subito dettero risposta
definitiva: Maradona è meglio ‘e Pelé. dell’eccesso,
fino alla rovinosa caduta dall’altare nella polvere. Il
santino di Diego è tornato presto lassù per essere
adorato anche da chi non ha mai avuto la fortuna di
vederlo giocare dal vivo. Il miracolo laico di Maradona
è proprio qui: attraversa le classi, le generazioni, le
nazioni, fino a unificare nel suo nome il mondo intero.
Da qualche anno nessuno o quasi propone più quell’insopportabile
quesito al quale i napoletani subito dettero risposta
definitiva: Maradona è meglio ‘e Pelé.
Vincere due scudetti, là dove mai si era vinto qualcosa
di più prezioso di una Coppa Italia o di una Coppa delle
Alpi, ha rappresentato l’evento prodigioso che non
sospettavano neppure gli ottantamila napoletani radunati
in un pomeriggio di luglio dell’84 al San Paolo solo per
vedere lui, il Profeta che prometteva gloria per tutti.
E gloria fu. La certezza fu raggiunta il pomeriggio di
Napoli-Juventus, 3 novembre 1985. Quel pallone, toccato
da Pecci a Maradona e spedito là dove Tacconi non
sarebbe mai arrivato, fu il campanello che annunciò il
cambio di direzione della fortuna. Erano giusto dodici
anni che la Signora Omicidi (allora la chiamavano così)
sbarcava a Napoli e se ne tornava imbattuta, nonostante
spesso la vigilia delle partite trascorresse insonne per
i giocatori, frastornati dall’ammuina organizzata
scientificamente dai tifosi napoletani. La dittatura era
finita, l’esercito di liberazione dei sogni napoletani
era guidato da Pancho Villa-Maradona.
Fu davvero rivoluzione. E’ vero che solo qualche mese
prima il Verona aveva vinto uno scudetto
 storico,
ma si fermò lì, il Napoli invece avrebbe aperto un
ciclo: primo nell’87 con l’aggiunta della Coppa Italia,
secondo per suicidio l’anno successivo, Coppa Uefa
nell’89, ancora scudetto nell’anno dei mondiali e infine
Supercoppa. storico,
ma si fermò lì, il Napoli invece avrebbe aperto un
ciclo: primo nell’87 con l’aggiunta della Coppa Italia,
secondo per suicidio l’anno successivo, Coppa Uefa
nell’89, ancora scudetto nell’anno dei mondiali e infine
Supercoppa.
Quattro stagioni vissute intensamente: la Juventus fu
messa da parte, gli avversari si chiamavano soprattutto
Milan (era agli inizi l’era Sacchi) e Inter (quella del
Trap e del record di punti conquistati), poi la Samp
degli emergenti Vialli&Mancini. Da questa parte, dalla
nostra parte, soprattutto Maradona. Chiedete ai compagni
di allora quanto sia stato determinate, tutti vi
risponderanno che è stato l’unico a poter vincere da
solo, quando il resto della squadra era stanco,
affaticato o anche semplicemente più scarso degli
avversari.
In mezzo anche un titolo di campione del mondo,
conquistato pure quello in solitudine da Diego,
circondato da onesti gregari e con un medico in
panchina, Carlos Bilardo, bravo soprattutto a sfruttare
il genio che tutti gli altri gli invidiavano. Aveva il
mondo ai suoi piedi quel giorno Diego, quando tolse la
scena al suo presidente, Carlos Menem. Dal balcone della
Casa Rosada dominava l’Argentina, ma già pregustava
l’altro trionfo: in fondo la sua nazionale un mondiale
lo aveva già vinto, il Napoli da sessant’anni attendeva
la consacrazione.
Dall’album dei ricordi ora emergono solo sorrisi, città
impazzita, festa popolare indimenticabile, perfino
l’immagine notturna di corso Buenos Aires, il rettifilo
di Milano, paralizzato dal traffico dei
 napoletani
all’estero. E il sorriso da bambino di Maradona, il più
felice di tutti. Intorno tutti erano comprimari:
Ferlaino, Bianchi e Bigon, Allodi, Marino e poi Moggi,
gli altri campioni che pure formavano quella squadra, da
Careca e Giordano, a Bagni e Ferrara. Altrove sarebbero
stati primattori, qui erano esaltati di servire il
Signore del calcio, l’eterno ragazzo che riassume in un
corpo un po’ tozzo l’essenza del calcio. napoletani
all’estero. E il sorriso da bambino di Maradona, il più
felice di tutti. Intorno tutti erano comprimari:
Ferlaino, Bianchi e Bigon, Allodi, Marino e poi Moggi,
gli altri campioni che pure formavano quella squadra, da
Careca e Giordano, a Bagni e Ferrara. Altrove sarebbero
stati primattori, qui erano esaltati di servire il
Signore del calcio, l’eterno ragazzo che riassume in un
corpo un po’ tozzo l’essenza del calcio.
Annerite dall’oblio le altre istantanee: le facce
bugiarde di Moggi impegnato in improbabili
giustificazioni di assenze sempre più frequenti, le
prime esplicite richieste di cambiar aria. Nessuno come
Maradona ha saputo farsi del male, la strada verso
l’autodistruzione l’ha imboccata più volte. Sembrava
finita, l’avventura, quando fu ricoverato in una clinica
di Baires. Fuori, in una veglia continua, stazionavano
migliaia di ragazzini che non avevano fatto in tempo a
tifare per lui. Lo facevano adesso che stava giocando la
partita più difficile. E c’erano altri ragazzini anche
il giorno del ritorno a Napoli. Stadio San Paolo
stracolmo per l’addio al calcio di Ciro Ferrara. Fu la
festa per Diego, restituito alla vita. Non ha più la
faccia impertinente dello scugnizzo cresciuto per caso
nel Barrio Fiorito, ma nessuno riesce a leggergli le
rughe sul viso. Sarebbe come scoprire che siamo noi a
essere invecchiati. E davanti a Diego ci sentiamo tutti
ragazzini.
Massimo Corcione
Nelle foto: in alto
a destra, Ferlaino presenta Maradona ai tifosi
napoletani nel San Paolo stracolmo nel 1984; in alto a
sinistra uno striscione dedicato al "pibe de oro" in una
strada di Napoli; al centro, Maradona mentre balla nella
trasmissione televisiva "Ballando con le stelle" del
2005; in basso, Diego saluta la folla del San Paolo in
occasione dell'addio al calcio di Ciro Ferrara nel 2005.
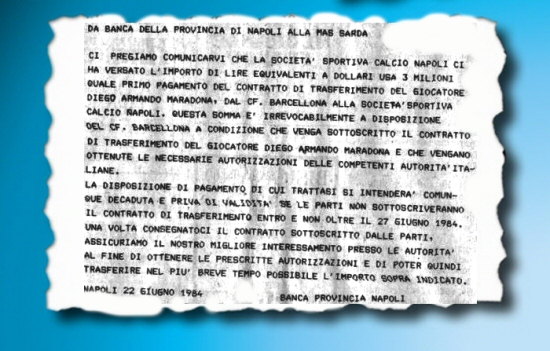
IL FAX PER L'ACQUISTO DI
MARADONA - Ecco il fax inviato
il 22 giugno del 1984 dalla Banca della Provincia di
Napoli alla Mas Sarda, e quindi al Barcellona, con il
quale veniva assicurato il versamento da parte del
Calcio Napoli della somma di tre milioni di dollari per
il trasferimento di Diego Maradona alla società
partenopea. L'acquisto del grande giocatore argentino
era virtualmente concluso. Il resto lo farà Corrado
Ferlaino in Lega. Per il Napoli stava per cominciare
un'era trionfale.
El pibe: una vita di successi, ma anche di guai

Diego
Maradona, una vita di eccessi, di alti e bassi,
sorprendente nel bene e nel male. Grandi momenti di
gioia nei suoi inimitabili trionfi, giorni di tristezza,
di dolore nei suoi momenti neri, in bilico costante
sull'orlo di un precipizio. Infortuni, problemi con la
cocaina, con il fisco, con un figlio non riconosciuto,
col divorzio. Dopo aver dato il doveroso tributo al
campione indiscusso del calcio, ecco in sintesi i suoi
giorni peggiori. Ne ha avuti tanti, ma li ha anche
voluti.
1982: IN SPAGNA EPATITE E
COCAINA - Già considerato un gran
campione anche se non ancora come “ il migliore d’ogni
tempo”, Maradona comincia ad accusare i suoi primi guai
fisici a Barcellona, al suo trasferimento in Spagna. Si
becca, infatti, un’epatite, quella A, alimentare, e
resta fuori squadra cento giorni. Intanto, sembra che
proprio a Barcellona Maradona comincia a fare la
conoscenza della polvere bianca, la cocaina che poi gli
stroncherà la carriera anzitempo
1983: UNA CAVIGLIA QUASI IN
FRANTUMI - Al “Camp Nou” il difensore
basco Andoni Goicoechea, con un’entrata assassina gli
spacca la caviglia. Maradona corre davvero il rischio di
non giocare più a pallone. Operato, con una caviglia
tenuta assieme da viti e fili, dopo una lunga
convalescenza e riabilitazione, riesce a tornare in
campo e a tornare quello di prima.
1991: DROGATO, LASCIA IL NAPOLI - E' il
17 marzo. A Napoli, dopo aver vinto due scudetti e una
Coppa Uefa, arrivano guai seri. Al controllo antidoping,
a conclusione di Napoli - Bari, Maradona risulta
positivo alla cocaina. Gli affibbiano 15 mesi di
squalifica. Si rompe il rapporto con la società azzurra.
Il primo aprile Diego lascia Napoli e torna in
Argentina, portandosi dietro irrisolto anche il caso
Sinagra: una giovane napoletana, Cristiana Sinagra,
figlia di un parrucchiere del Vomero, aveva accusato
Diego, davanti alle telecamere del Tg1, di essere padre
di Diego Armando Jr. proprio qualche giorno dopo che
Claudia Villafanes, fidanzata ufficiale del "Pibe de
oro" aveva annunciato di aspettare un bambino da lui. La
successiva sentenza del Tribunale si sarebbe pronunciata
a favore della donna.
1991: E IN ARGENTINA LO
ARRESTANO - Il 26 aprile la polizia
argentina arresta Maradona, sorpreso in un appartamento
del «barrio de Castillo» assieme con alcuni amici e in
possesso di cocaina. Stranamente, si aspettano le
telecamere, i giornalisti e i flash dei fotografi per
far uscire Maradona da quell’appartamento e a molti in
Argentina quell’arresto sembra addirittura preparato per
distogliere l’interesse della gente dai problemi della
politica e dell’economia argentina. Il tribunale ordina
per Maradona un trattamento di disintossicazione.
1994: DOPING ANCHE AI
MONDIALI - Ai mondiali di calcio negli
Stati Uniti, Diego –completamente recuperato e
restituito al grande calcio – risulta positivo al
controllo anti-doping dopo Argentina-Nigeria giocata a
Boston. Maradona, molto turbato, apprende della
sospensione nella sua stanza d’albergo a Dallas, mentre
la sua Nazionale è allo stadio per un’altra gara dei
mondiali. Maradona si dichiara vittima di un complotto.
Il 24 agosto la Fifa lo condanna a 15 mesi di stop.
1997: RICOVERO IN OSPEDALE
- Ormai non ci sono più segreti, smentite o sotterfugi.
La dipendenza del “pibe” dalla cocaina è ormai evidente
e dichiarata. Il 18 aprile, a Santiago del Cile, mentre
partecipa ad una trasmissione televisiva condotta da
miss Universo, un innalzamento pressorio lo costringe a
trascorrere per precauzione una notte in ospedale.

1997: POSITIVO ANCHE NEL
BOCA - Irriducibile, con grande forza
d’animo, prepara un altro rientro. Tornato in campo col
suo Boca Juniors, il 28 agosto, Maradona è fermato dalla
Federcalcio argentina perché all’esame antidoping alla
fine di Boca - Argentinos Juniors è trovato di nuovo
positivo.
2000: A CUBA PER DISINTOSSICARSI - Il 4
di gennaio, mentre è in vacanza a Punta del Este, in
Uruguay, è ricoverato d’urgenza per una crisi
ipertensiva ed una forte aritmia. Rischia la vita. Il
suo stile di vita viene condannato dai medici. Dimesso,
si trasferisce a Cuba, all’ombra del suo grande
ammiratore Fidel Castro, per disintossicarsi.
2004: ATTACCO DI CUORE
- Il 18 aprile, nuova crisi cardiaca, stavolta aggravata
da una infezione polmonare. In gravi condizioni, Diego
finisce in ospedale a Buenos Aires. C’è chi parla di
attacco di cuore a seguito di overdose di cocaina. Vi
resta a lungo, ma vince un’altra volta la sua partita
con la morte. Giorni dopo l'attacco di cuore,
un'infermiera fu sorpresa a fotografare Maradona con un
telefono cellulare e fu prontamente licenziata
dall'ospedale. Sempre nel 2004 Diego divorzia da Claudia
Villafanes, ma resterà in buoni rapporti con la moglie,
grazie anche alle due figlie.
2004: ECCESSI ALIMENTARI E ALCOOL -
Un’altra sua debolezza: la trasgressione alimentare a
tavola. Così accertano i medici argentini quando torna
ancora una volta in ospedale e sempre a Buenos Aires.
Stavolta la degenza dura poco. Ma gli eccessi
alimentari, accompagnati dall’uso abbondante di alcool
ne segnano la sorte. Aumenta di peso a vista d'occhio.
Le foto di Maradona ingrassato sono impressionanti.

2005: GONFIO E PESANTE, POI
TORNA IN FORMA - Il suo cuore che
funziona ormai al venticinque-trenta per cento non
sopporta più quel suo corpo appesantito. E così Maratona
– che era apparso in Tv gonfio e deforme, va in Colombia
per sottoporsi ad una resezione gastrica. In poco tempo
scende da 116 a 76 chili e appare felice, completamente
recuperato. Volentieri si offre per trasmissioni
televisive, anche come conduttore e scattante ballerino.
Assicura spesso la sua presenza in tribuna per assistere
a incontri di calcio. Nel dicembre, suo figlio, Diego
jr. avuto a Napoli dalla Cristiana Sinagra nel 1986,
dichiara di voler denunciare il padre per "mancata
assistenza familiare, diffamazione e danni morali" dopo
che Diego ha definito “un errore” la sua nascita. "Pago
col denaro i miei errori” aveva detto Diego in
Argentina: «Accettare non significa riconoscere». Diego
Junior – dopo il riconoscimento del Tribunale - era
riuscito a parlare con il padre naturale solo nel maggio
del 2003,
quando con un sotterfugio entrò di nascosto nel campo da golf di Fiuggi
dove l'ex campione stava giocando una partita. Alla fine
il ragazzo disse che il padre gli aveva promesso che si
sarebbero rincontrati. Un impegno mai rispettato. Fu il
primo ed ultimo incontro. Tutto
questo mentre si susseguivano i guai fiscali. Maradona
deve al fisco italiano 31 milioni di Euro. Questo fatto
è stato accertato definitivamente dalla Cassazione con
una sentenza a febbraio.
2007: EPATITE TOSSICA E ALCOLICA -
Maradona, il 29 marzo, a seguito di un continuo abuso di
fumo (quattro sigari Avana al giorno) ed alcool viene
ricoverato nel Sanatorio Guemes di Buenos Aires, dopo aver
accusato uno scompenso cardiaco, proprio mentre stava
per imbarcarsi su un aereo che lo avrebbe trasportato in
Svizzera per sottoporsi ad una terapia per dimagrimento.
Dopo pochi giorni di cura ed accertamenti, i medici
della clinica stabiliscono che si tratta di epatite
tossica ed alcolica. Nel giro di una settimana viene
accertato un netto miglioramento. Il direttore della
clinica, Pezzella, smentisce che Diego, depresso, abbia
tentato il suicidio. Subito dopo essere stato dimesso,
Maradona è costretto ad un nuovo ricovero per un altro
malore con forti dolori addominali. Si teme una
pancreatite, per abuso di alcool. Ma un medico argentino
che l'ha curato ha sentenziato:" Il vero problema di
Maradona è che si crede un Padreterno E pensando di
essere immortale non si è risparmiato alcool e
abbuffate, a parte il fumo". Dopo una lunga cura
, torna a casa, va in Tv, attacca il governo, chi lo ha
dato per morto e annuncia di "voler assolutamente
tornare a Napoli"
2007: CHIEDE SCUSA E FA PACE
COL FIGLIO - Il 21 novembre , dopo tante
diatribe, Maradona chiede scusa al figlio Diego, nato
dalla Sinagra, e si riconcilia davanti al tribunale di
Napoli. Due anni prima durante uno show televisivo, "la
noche del 10" a Buenos Aires, riferendosi al figlio
napoletano, Maradona aveva detto " sto pagando col
denaro un errore del passato". Per questa frase ritenuta
diffamante e per aver interrotto il versamento degli
alimenti, Maradona fu querelato dal figlio. Davanti al
Tribunale di Napoli la riconciliazione. L'ex campione
con una nota chiede scusa al figlio al quale vanno anche
un risarcimento simbolico (poche migliaia di euro). Maradona, inoltre, versa gli arretrati ed
anticipa anche tutti gli alimenti dovuti fino ai
venticinque anni del figlio. "Più che rancore, odio, ho
provato soprattutto rabbia" ha commentato Diego junior.
"La rabbia che prova un figlio che in determinati
momenti della sua vita non ha un padre accanto a sé. Ora
però sono cresciuto, ora ho capito chi è davvero nella
mia vita, ogni giorno". Inevitabile, una domanda sulla
possibilità di un incontro. Lui, a prendere un aereo per
inseguire il padre non ci pensa proprio. "Se vuole
incontrarmi - dice senza mezzi termini - deve essere lui
a venire qui. Io non andrò da nessuna parte". Dal
2006 Maradona, dopo la separazione dalla moglie Claudia
Villafane, madre delle due figlie di Diego, vive con una
nuova compagna, la giovane e biondissima Veronica Ojeda.
La coppia vive nella zona dell'aeroporto di Ezeiza.
Nella foto, Maradona con Veronica durante una festa
mascherata in Argentina. L'ex campione
con una nota chiede scusa al figlio al quale vanno anche
un risarcimento simbolico (poche migliaia di euro). Maradona, inoltre, versa gli arretrati ed
anticipa anche tutti gli alimenti dovuti fino ai
venticinque anni del figlio. "Più che rancore, odio, ho
provato soprattutto rabbia" ha commentato Diego junior.
"La rabbia che prova un figlio che in determinati
momenti della sua vita non ha un padre accanto a sé. Ora
però sono cresciuto, ora ho capito chi è davvero nella
mia vita, ogni giorno". Inevitabile, una domanda sulla
possibilità di un incontro. Lui, a prendere un aereo per
inseguire il padre non ci pensa proprio. "Se vuole
incontrarmi - dice senza mezzi termini - deve essere lui
a venire qui. Io non andrò da nessuna parte". Dal
2006 Maradona, dopo la separazione dalla moglie Claudia
Villafane, madre delle due figlie di Diego, vive con una
nuova compagna, la giovane e biondissima Veronica Ojeda.
La coppia vive nella zona dell'aeroporto di Ezeiza.
Nella foto, Maradona con Veronica durante una festa
mascherata in Argentina.
|
Maradona ha vinto di tutto e di
più
 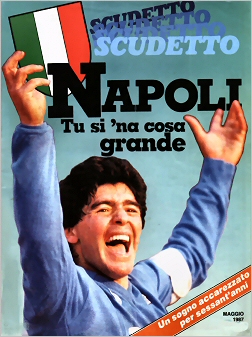
Dal
20 ottobre 1976 ( quando debuttò quindicenne in Prima
Divisione nell’Argentinos Junior contro il Talleres de
CordobaI) al 25 ottobre 1997 ( data dell'ultima partita
ufficiale, con la maglia del Boca Juniors contro il
River Plate, battuto per 2-1), Diego Maradona ha vinto
di tutto e di più: un Mondiale dei big (nel 1986) e uno
dei giovani (nel 1979), tre scudetti (uno con il Boca,
nel 1981, due con il Napoli nel 1987 e nel 1990), una
Coppa Uefa in azzurro (nel 1989), una Coppa Italia e una
Supercoppa italiana sempre col Napoli, una Coppa del Re
con il Barcellona, vincendo anche la classifica
dei cannonieri in Italia nell’87-88 con 15 gol. Maradona
ha conquistato pure un Pallone d'oro alla carriera,
consegnatogli nel '95. Ha vinto, infine, il
prestigioso titolo di “Calciatore del secolo”
organizzato dalla Fifa con un sondaggio nel 2000. Unico cruccio, la
Coppa dei Campioni. Quella sudamericana, la Libertadores,
Diego non l'ha mai neppure giocata, quella europea l'ha
visto fuori al primo turno con il Napoli contro il Real
Madrid. Ha disputato quattro campionati del mondo. Due le
esperienze da allenatore: nel 1994 viene ingaggiato dal
Deportivo Mandiyú di Corrientes, ma due mesi dopo
rinuncerá all'incarico. Seconda esperienza da allenatore
nel 1995: lo assume il Racing Club di Avellaneda. Quattro mesi dopo
dará le dimissioni.
|
|
Juliano, una storia che sembra una favola
di
Toni Iavarone

Giocare
nel Napoli per lui è stato un gesto naturale. Lo sognava
da ragazzino. E come in un sogno Antonio Juliano il 17
febbraio 1963 debutta in serie A, al San Paolo, in una
partita sfortunata, che gli azzurri perdono 5-1 con
l'invincibile Inter di quegli anni. Le storie dei grandi
personaggi spesso iniziano così, con una delusione,
prima di mille momenti di gloria. E di attimi
indimenticabili Juliano ne vive tanti, spalmati in una
lunga carriera da calciatore, terminata a fine anni '70
a 36 anni, costruita tassello dopo tassello, con 502
maglie azzurre e alcune vittorie che per il Napoli di
allora valevano come scudetti: Coppa Italia nel 1976 e
quei trofei meno importanti, ma a cui siamo ancora tanto
affezionati, come Coppa delle Alpi e Coppa Italo-Inglese.
Lo scugnizzo di San Giovanni a Teduccio indossa la fascia di
capitano del Napoli a soli 23 anni. E ' un duro, si
allena tanto e affina una tecnica già buona. Sa tirare
da fuori area come pochi in Italia, è un uomo d'ordine
che in azzurro diventa regista assoluto, indossando la
maglia numero 8, quasi a dimostrare al mondo che si può
essere bandiere e leader di una grande squadra anche
senza il "10" sulle spalle. Un tipo così, che dalle
nostre parti chiamarono subito il "Golden boy" del
Napoli, incuranti dei suoi colori neri mediterranei, in
Nazionale ci arriva naturalmente. E con la maglia
dell'Italia Totonno vive e scrive pagine di calcio
incancellabili C'è lui, l'orgoglio dei napoletani, ad
alzare la Coppa Europa con l'Italia a Roma nel '68. E
c'è sempre lui, prima spettatore privilegiato dalla
panchina in Italia-Germania 4-3, poi in campo, nel
giorno triste della finale con il Brasile. E Impazzisce
di gioia quando lo convocano nella nazionale del Resto
del Mondo. Lui, lo scugnizzo del Napoli, al fianco di
fuoriclasse come Cruyff e Beckenbauer.
 Qualche
rammarico trova comunque posto tra le mille gioie di
Juliano. La Juve gli porta via lo scudetto del '75:
nessun antico tifoso azzurro ha mai dimenticato quel
decisivo Juve-Napoli 2-1, mentre ad Agnano andava in
scena il “Lotteria”. Juliano era indemoniato: un gol
spettacolare da fuori area e un altro, fotocopia, che
Dino Zoff gli nega con un volo infinito, prima del
tradimento di Altafini, con quel drammatico gol del 2-1,
che pugnala a morte il suo Napoli a due passi dal
titolo. Non solo azzurro c'è anche una macchia di colore
rosso-blu nella sua carriera, quando Juliano gioca
l'ultima stagione da calciatore con la maglia del
Bologna. E' una ripicca, la reazione di un innamorato
tradito: Corrado Ferlaino gli prepara un addio che lui
non ha deciso e il "Totonno furioso" se ne va da
avversario a Bologna, prima di mettere la parola fine
alla sua splendida carriera di calciatore. Qualche
rammarico trova comunque posto tra le mille gioie di
Juliano. La Juve gli porta via lo scudetto del '75:
nessun antico tifoso azzurro ha mai dimenticato quel
decisivo Juve-Napoli 2-1, mentre ad Agnano andava in
scena il “Lotteria”. Juliano era indemoniato: un gol
spettacolare da fuori area e un altro, fotocopia, che
Dino Zoff gli nega con un volo infinito, prima del
tradimento di Altafini, con quel drammatico gol del 2-1,
che pugnala a morte il suo Napoli a due passi dal
titolo. Non solo azzurro c'è anche una macchia di colore
rosso-blu nella sua carriera, quando Juliano gioca
l'ultima stagione da calciatore con la maglia del
Bologna. E' una ripicca, la reazione di un innamorato
tradito: Corrado Ferlaino gli prepara un addio che lui
non ha deciso e il "Totonno furioso" se ne va da
avversario a Bologna, prima di mettere la parola fine
alla sua splendida carriera di calciatore.
Tormenti, gioie e dolori a più riprese, anche nei suoi
anni da dirigente. In giacca e cravatta, lo sguardo
serio e imbronciato di chi la sa lunga ma non vuol dire, Juliano vive momenti che passano alla storia, nel bene e
nel male. E' Direttore Generale nella stagione 1980-1981
quando a cinque giornate dal termine del campionato la
nostra città è già imbandierata di tricolori e
d'azzurro, con il Napoli in testa alla classifica,
assieme a Juve e Roma. Juliano assiste attonito al
dramma azzurro d'aprile, in una delle partite-beffa più
assurde della storia del Napoli: il Perugia ultimo e
retrocesso passa al San Paolo con un'autorete di
Ferrario. E addio sogni di gloria e di scudetto.
 Juliano frequenta da dirigente generale del Napoli anche
gli alberghi di lusso di Barcellona, in quell'indimenticabile
inizio estate del 1984. Sul contratto di Diego Armando
Maradona al Napoli non c'era la firma di Totonno ma
quella di Ferlaino. Ma in fondo, è come se ci fosse
stata, perchè in quella trattativa lunga e difficile, a
volte stucchevole e paradossale, Juliano non mollò mai,
tignoso e cocciuto napoletano, in perenne duello
dialettico e di furberie con quel vice presidente del
Barcellona Gaspart, antipatico e impopolare come pochi.
Peccato solo per quell'addio amaro prima delle glorie e
degli scudetti azzurri degli anni di Diego. Juliano
lavorava con il solito impegno ma c'era già il grande
Italo Allodi a programmare il presente e il futuro del
Napoli. Brutti scherzi di Ferlaino. Nè il suo ritorno di
fiamma da dirigente a fine anni '90 in serie B, passerà
mai agli annali. Poco importa: c'è così tanto da
ricordare quando si parla del capitano azzurro, che le
ombre della sua lunga carriera, lasciano il posto e si
perdono tra le luci del suo mito.
Juliano frequenta da dirigente generale del Napoli anche
gli alberghi di lusso di Barcellona, in quell'indimenticabile
inizio estate del 1984. Sul contratto di Diego Armando
Maradona al Napoli non c'era la firma di Totonno ma
quella di Ferlaino. Ma in fondo, è come se ci fosse
stata, perchè in quella trattativa lunga e difficile, a
volte stucchevole e paradossale, Juliano non mollò mai,
tignoso e cocciuto napoletano, in perenne duello
dialettico e di furberie con quel vice presidente del
Barcellona Gaspart, antipatico e impopolare come pochi.
Peccato solo per quell'addio amaro prima delle glorie e
degli scudetti azzurri degli anni di Diego. Juliano
lavorava con il solito impegno ma c'era già il grande
Italo Allodi a programmare il presente e il futuro del
Napoli. Brutti scherzi di Ferlaino. Nè il suo ritorno di
fiamma da dirigente a fine anni '90 in serie B, passerà
mai agli annali. Poco importa: c'è così tanto da
ricordare quando si parla del capitano azzurro, che le
ombre della sua lunga carriera, lasciano il posto e si
perdono tra le luci del suo mito.
Toni Iavarone
Nelle foto: in
alto, Juliano con Vinicio, due idoli del Napoli durante
un Napoli-Vicenza al San Paolo; al centro, Attila
Sallustro premia Antonio Juliano, capitano del Napoli,
per le sue prestazioni in Nazionale; in basso, Antonio
Juliano, opinionista Tv con Toni Iavarone.
Ad Attila solo una "Balilla" in cambio di tanti
gol
di
Mimì Pessetti

L’anno
venturo, nel 2008, ricorre il centenario dalla nascita
di questo grande personaggio che è stato un po’ campione
e un po’ divo. Attila Sallustro nasce ad Asuncion da
genitori italiani e benestanti. Ancora giovinetto, viene
in Italia. Due fratelli: Oreste che giocherà nel Napoli
e Oberdan che finirà vittima del terrorismo in Sud
America. Oreste e Oberdan studiano ingegneria. Nei
progetti paterni anche ad Attila viene indicata una
strada professionale da borghese medio-alto, ma il
ragazzo coltiva ben altri istinti. La figura slanciata,
il portamento elegante, il gusto per le cose belle della
vita, forse anche un’inevitabile tendenza a stare sotto
i riflettori. L’occasione gli viene offerta dai primi
campi di calcio.
Nella stagione 1925-26, a soli 17 anni, diventa titolare
dell’Internaples, siglando persino una tripletta alla
Messinese. Siamo alla svolta epocale del calcio
partenopeo. Giorgio Ascarelli, impareggiabile presidente
azzurro, trasforma la vecchia Internaples in
Associazione Calcio Napoli e ottiene un posto nel primo
campionato nazionale a girone unico. Qui comincia
l’ascesa del campione che dopo un paio di stagioni
diventa titolare inamovibile, cannoniere scelto, idolo
dei tifosi.
Il padre, visti traditi i suoi progetti, benedice la
scelta del figlio di tirare calci al pallone. Gli
impone, però, di non fare affidamento sui guadagni del
calcio. Attila gioca senza chiedere soldi, creando
imbarazzo ai dirigenti azzurri, i quali, per sdebitarsi
e per dimostrargli una benché minima gratitudine, gli
aprono nel 1932 la portiera di una fiammante Fiat 521 e
lo fanno accomodare. “E’ tua – gli dicono – va pure a
tutto gas!”. Attila pilota l’auto per le vie del centro
e parcheggia nel bel mezzo di Piazza del Plebiscito.
Accorre un nugolo di fotoreporter e così viene
immortalato il delizioso campione col gradito trofeo.
Sallustro è nel pieno del suo vigore atletico. Si sente
ammirato e dunque realizzato. La città lo ama, i tifosi
impazziscono per lui e lui li ripaga a suon di gol. Che
cosa gli manca? Sembra strano, ma qualcosa gli manca.
Intanto aspetta la definitiva consacrazione che solo una
chiamata in Nazionale può dargli. Carlo Carcano,
selezionatore azzurro, ignora le qualità del “veltro”
(così è soprannominato Attila per la sua elegante
falcata). Carcano, però, non può durare in eterno. Gli
subentra Vittorio Pozzo che comincia ad allestire lo
squadrone che vincerà due titoli mondiali (’34 e ’38) ed
un’Olimpiade (’36 a Berlino).
Il nuovo ct alla prima convocazione chiama Sallustro e lo manda in
campo contro il Portogallo. Attila non è solo. Al suo
fianco c’è un altro calciatore del Napoli, Mihalich. Per
l’Italia è un trionfo. I lusitani vengono battuti con un
tennistico 6-1 e un gol lo fa il “veltro”. Si gioca a
San Siro, davanti ai supporter di Peppino Meazza,
l’astro nascente del calcio italiano che in seguito
risulterà un ostacolo inesorabile per il nostro campione
sulla strada della Nazionale..
 Sallustro-Meazza,
un dualismo che divide il Nord ed il Sud. A conti fatti
un dualismo impari, certamente non all’altezza di quello
tra Bartali e Coppi o, per tornare al calcio, di quello
tra Mazzola e Rivera. Qui, a penalizzare Sallustro,
intervengono precisi fattori. Meazza è più giovane,
gioca nell’Ambrosiana-Inter e questo geopoliticamente lo
avvantaggia. Senza tener conto che l’Ambrosiana vince
scudetti, mentre il Napoli veleggia nel centro della
classifica. Cosa può fare Attila per far cambiare idea a
Pozzo? Nulla o quasi. Gli riesce solo di strappare una
seconda presenza contro la Svizzera, a Napoli, nello
stadio intitolato a Giorgio Ascarelli. E gli resta anche
qualche magra rivincita negli scontri diretti in
campionato, come quando il Napoli batte l’Ambrosiana
(3-1) di Meazza e due gol li mette a segno proprio il
centravanti partenopeo. Una consolazione. Sallustro-Meazza,
un dualismo che divide il Nord ed il Sud. A conti fatti
un dualismo impari, certamente non all’altezza di quello
tra Bartali e Coppi o, per tornare al calcio, di quello
tra Mazzola e Rivera. Qui, a penalizzare Sallustro,
intervengono precisi fattori. Meazza è più giovane,
gioca nell’Ambrosiana-Inter e questo geopoliticamente lo
avvantaggia. Senza tener conto che l’Ambrosiana vince
scudetti, mentre il Napoli veleggia nel centro della
classifica. Cosa può fare Attila per far cambiare idea a
Pozzo? Nulla o quasi. Gli riesce solo di strappare una
seconda presenza contro la Svizzera, a Napoli, nello
stadio intitolato a Giorgio Ascarelli. E gli resta anche
qualche magra rivincita negli scontri diretti in
campionato, come quando il Napoli batte l’Ambrosiana
(3-1) di Meazza e due gol li mette a segno proprio il
centravanti partenopeo. Una consolazione.
Attila Sallustro è tuttavia un campione autentico. Non si rammarica
per questa concorrenza impari. Pensa al suo Napoli,
pensa a godersi il successo che i tifosi gli tributano.
Però gli manca ancora qualcosa.e in questo qualcosa ben
presto s’imbatte. E’ come un pallone che arriva dalle
sue parti e lui lo stoppa con naturale eleganza, per
filare a rete come solo lui sa fare.
Elena Johnson è nata a Mosca. Sua madre, Lidia Abramovic, è una
ballerina russa che si fa chiamare Ise Bluette, ex
vedette delle Folies Bergeres. La giovane Elena segue le
orme materne e sceglie un nome d’arte destinato a
diventare famoso: Lucy d’Albert. Viene scritturata al
Teatro Nuovo, a Napoli. Attila non disdegna le luci del
varietà e una sera va al Nuovo con un manipolo di amici.
Le evoluzioni del corpo sinuoso di Lucy lo affascinano e
a fine spettacolo corre in camerino per conoscerla.
Lucy, si dice, ha una storia con Umberto di Savoia, ma
il colpo di fulmine per il bellissimo campione è
inevitabile. Si sposano e le malelingue sentenziano che
con le nozze comincia il lento e inesorabile declino del
calciatore. Gli viene preferito Guglielmo Glovi, bomber
di Bagnoli. Attila appende le scarpette al chiodo.
Rimane nell’orbita azzurra solo per una breve sosta
sulla panchina del Napoli, chiamato a sostituire il
tandem Cesarini-Amadei. E’ il campionato 1960-61: a due
giornate dalla fine il Napoli è già condannato alla
serie B.
Viene nominato direttore del nuovo stadio San Paolo, quello stesso
stadio che molti volevano dedicargli, così come è
accaduto a Milano per Meazza. Napoli si dimostra invece
ingrata ed oggi solo una stradina periferica a
Ponticelli, di fronte al Parco Azzurro, reca il nome di
Attila Sallustro, nonostante tutto uno dei tre o quattro
miti della storia calcistica partenopea.
Mimì Pessetti
Nelle foto: il
alto, Sallustro immortalato in Piazza del
Plebiscito con la fiammante "Balilla" regalatagli dal
Calcio Napoli nel 1932, per compensarlo delle sue
prestazioni; al centro, Attila nel 1936 con la
moglie Lucy D'Albert ed il figlio Alberto, di pochi
mesi, che attualmente vive a Roma.
Vinicio, il cuore di un leone
di
Nino Masiello

“Dona”
Orozina non amava soltanto l’insegnamento delle materie
d’obbligo alle elementari di Belo Horizonte, amava anche
il calcio, e quei cinque ragazzini che vedeva al termine
delle lezioni contendersi una piccola palla di gomma,
nel cortile della scuola, la mandavano in sollucchero.
Perché ogni giorno miglioravano i “fondamentali”,
imparavano a dribblare e, uno, in particolare, già
calciava al volo che era proprio un piacere.
Quel campioncino in erba, specialista nei tiri in porta, si
chiamava Luiz de Menezes, apparteneva a una famiglia
borghese di Belo Horizonte, destinato a diventare un
professionista, con una sorella già insegnante di
educazione fisica fidanzata con un aitante maestro di
tennis. Furono proprio la sorella, Luisa, e il cognato,
a prepararlo adeguatamente sul piano fisico per aiutarlo
a sostenere i primi impegni ufficiali in una squadra di
quartiere, gli “Aventureros”, iscritta ai campionati
giovanili. Correva l’anno 1947, il futuro campione della
prima squadra di Belo Horizonte, città brasiliana di
circa mezzo milione di abitanti, stato del Minas Gerais,
di anni ne aveva quindici e, per parenti e amici, era
già Vinicio.
Dagli “Aventureros” alla “Metallusina”, al “7 Settembre” di don
Antonio Lunardi, suo grande mentore, e di Jair de Assis,
suo primo maestro che, in allenamento, lo faceva marcare
anche da tre avversari per migliorarne tenuta e tenacia:
Quel Jair che lo portò a completarsi come centravanti di
sfondamento che si faceva largo prepotentemente, a forza
di gol, tra i moltissimi giovani emergenti del calcio di
Belo.
Al punto che, a diciotto anni appena compiuti, fresco di iscrizione
alla facoltà di architettura, il suo nome finì nel
taccuino del presidente del mitico Botafogo di Rio,
Carlito Rocha.
Affare fatto. Quattromilacinquecento cruzeiros al mese (novantamila
lire al cambio di allora, 1951), vitto, alloggio e tasse
universitarie pagate. Il giovanotto di provincia sbarca
a Rio e mette timidamente piede nella società che aveva
dato al calcio mondiale fuoriclasse come Didi, Garrincha,
Zagalo, Nilton Santos, Zezè Moreira, una sbornia
d’orgoglio per mamma Giuditta, per “Dona” Orozina, la
maestra-tifosa, per i nove fratelli de Menezes.
 Tre stagioni nel Botafogo e diventò “il leone” quando un
supertifoso inviò pochi versi della domenica a un
giornale sportivo di Rio per celebrarlo tale: “Vinicio,
il tuo nome è accetto, con la tua fama di campione tu
hai, nel petto, il cuore di un leone”. Sicchè, quando la
società di Rocha decise di inventarsi una tournè europea
per mettere in vetrina i suoi migliori giocatori,
Pasqualini, mediatore specializzato in affari con i
mercati sudamericani, suggerì ad Achille Lauro anche il
nome di quel “leone”.
Tre stagioni nel Botafogo e diventò “il leone” quando un
supertifoso inviò pochi versi della domenica a un
giornale sportivo di Rio per celebrarlo tale: “Vinicio,
il tuo nome è accetto, con la tua fama di campione tu
hai, nel petto, il cuore di un leone”. Sicchè, quando la
società di Rocha decise di inventarsi una tournè europea
per mettere in vetrina i suoi migliori giocatori,
Pasqualini, mediatore specializzato in affari con i
mercati sudamericani, suggerì ad Achille Lauro anche il
nome di quel “leone”.
Don Achille seppe che il Botafogo, dopo il Real, avrebbe fatto
visita agli svizzeri del Grasshoppers e poi sarebbe
arrivato a Torino per un’amichevole contro una mista
Juve-Toro.
“Il Napoli acquisterà Vinicio” proclamò ‘o comandante. Gino Palumbo,
insuperato maestro di giornalismo e di vita, andò a
vedere l’amichevole: “Vinicius ci è piaciuto più del suo
celebre compèagno Da Costa. Il biondo calciatore –
scrisse sul Mattino – a nostro avviso è un grandissimo
centravanti: affiancarlo a Jeppson, regolamento federale
permettendo, potrebbe essere una formidabile idea”.
Dopo Torino il Botafogo arrivò a Roma, che già si preparava ad
accogliere Da Costa in giallorosso. Altra bella prova
del “Leone”: “Stavo sotto la doccia – racconterà
Vinicio- a partita da poco conclusa, quando mi si
avvicinò un signore simpatico, sorridente, in compagnia
di Rocha. Disse il suo nome nel porgermi la mano, ma non
capii molto. Poco dopo, invece, Carlito mi disse che era
l’allenatore del Napoli, Monzeglio, il mio futuro
tecnico nel Napoli di Jeppson, il centravanti che avevo
tanto ammirato durante la Coppa Rimet del 1950”.
Il trasferimento fu perfezionato a fine agosto del 1955, il 18
settembre l’esordio in campionato, al “Vomero”, contro
il Torino: Bugatti, Comaschi, Greco II, Castelli, Tre
Re, Granata, Vitali, Posio, Vinicio, Amadei, Pesaola. La
partita era appena cominciata che Vinicio salutò Napoli
con una fulminea cannonata contro la porta di Rigamonti
e Cuscela, Bearzot, Grosso, Moltrasio rimasero
inebetiti. Vinicio segnò ancora. Poi il Napoli vacillò e
il Toro pareggiò i conti nei venti minuti finali.
Fermiamo qui le lancette dell’amarcord viniciano. Cinque stagioni
in azzurro, per due nel Bologna, quattro nel Vicenza
dove diventa capocannoniere nella stagione 1965-66, un
campionato nell’Inter, la chiusura ancora a Vicenza. Poi
le panchine, anche quella del “Napoli all’olandese”,
semplicemente straordinario e tosto. Proprio come il suo
maestro, entrato a buon diritto nella leggenda del più
bel calcio di tutti i tempi.
Nino Masiello
Nelle foto: in
alto, Vinicio mai domo, a bordo campo al Vomero, dopo un
infortunio di gioco. Alle sue spalle il Comandante
Achille Lauro. In basso, Vinicio sposo con Flora nel
giugno del 1957. Nel giro di quattro giorni convolarono
a nozze prima Vinicio e poi Jeppson, suo compagno di
squadre e...rivale.
|
|
Cannavaro, orgoglio napoletano
di Mimmo Carratelli
 Non c’è alcun dubbio che Fabiuccio
Cannavaro, from Naples at Loggetta, è la corona della
nostra testa e il piedistallo del nostro orgoglio,
campione del mondo del nostro cuore napoletano,
guerriero e palla di gomma, trasvolatore d’area,
barriera corallina, frangiflutti, torre, pedone e re dei
sedici metri, e ha meritato ampiamente il Pallone d’oro
e successivamente anche il titolo di "campione
dell'anno" 2006 (indetto dalla Fifa) davanti a Zidane ed
a Ronaldinho. Meriterebbe di tutto e di più: l’area di
rigore di platino, la respinta di rubino e il colpo di
testa di argento. Ma la strameritata incoronazione
parigina è l’ultima conferma di un calcio che va
all’indietro, si raggruppa in difesa, pressa, respinge e
distrugge ogni fantasia, però vincendo un campionato del
mondo.
Non c’è alcun dubbio che Fabiuccio
Cannavaro, from Naples at Loggetta, è la corona della
nostra testa e il piedistallo del nostro orgoglio,
campione del mondo del nostro cuore napoletano,
guerriero e palla di gomma, trasvolatore d’area,
barriera corallina, frangiflutti, torre, pedone e re dei
sedici metri, e ha meritato ampiamente il Pallone d’oro
e successivamente anche il titolo di "campione
dell'anno" 2006 (indetto dalla Fifa) davanti a Zidane ed
a Ronaldinho. Meriterebbe di tutto e di più: l’area di
rigore di platino, la respinta di rubino e il colpo di
testa di argento. Ma la strameritata incoronazione
parigina è l’ultima conferma di un calcio che va
all’indietro, si raggruppa in difesa, pressa, respinge e
distrugge ogni fantasia, però vincendo un campionato del
mondo.
Bene. Quel che conta è il risultato. Ma che il calcio
traboccante di euro, issato a spettacolo quotidiano
dalle tv, capace di far saltare le sedute del Consiglio
comunale a Napoli e bloccare il Parlamento a Roma,
diffuso dai satelliti dalla Cina al Canada e celebrato
persino dai gossip dei giornali rosa, non abbia che da
proporre un terzino al primo posto in Europa e un
portiere al secondo posto vorrà pur dire che il pallone
è diventato quadrato. E’ la celebrazione del deserto dei
tartari all’attacco nell’esaltazione di ogni fortezza,
fortino e forte, piazzaforte, linea Maginot, fossato e
filo spinato.
Ci sono stati difensori di grande bellezza atletica e fascino
tecnico, l’olandese Krol su tutti, ma anche il kaiser
Beckenbauer, l’amato Scirea, l’indimenticabile Armando
Picchi e il più recente Franco Baresi, di cui Fabio
Cannavaro è degnissimo erede, ma la scelta di un terzino
a re del football continentale stride con lo spirito del
gioco più bello del mondo la cui bellezza nasce e si è
nutrita in tutt’altri ruoli, il favoloso “numero 10” su
tutti, le ali volanti, i centravanti di grazia e di
sfondamento.
Il pallone d’oro nasce, nel 1956, col
premio a Stanley Matthews, l’ala destra che per le sue
finte infinite e il tiro minaccioso fu incoronata
baronetto. Ha innalzato sul podio l’immenso Alfredo Di
Stefano, la “saeta rubia” con nonni capresi, e Suarez,
Sivori, il panterone del Mozambico Eusebio, Bobby
Charlton, il disperato Best, gli essenziali Cruijff e
Platini, il tulipano Marco Van Basten e Zizou Zidane, e
i nostri Rivera, Paolo Rossi e Roby Baggio, fiori di un
giardino straordinario. E’ evidente che il giardino è
sfiorito. Le tattiche esagerate e il troppo danaro delle
vittorie indispensabili hanno disseccato il terreno.
Nessuno disegna più ghirigori di delizia sull’erba,
nessuno traccia più parabole magiche nel cielo degli
stadi, nessuno incanta più. Il Pallone d’oro,
retrocedendo da Ronaldinho a Cannavaro, fotografa il
calcio essenziale dei tempi post-moderni in cui è
aumentato il numero sulle maglie dei giocatori, ma lo
spettacolo è diminuito, e gli assi sono scomodi perché
uomini liberi che si sottraggono ai ceppi strategici.
Un piccolo, grande gladiatore vince su tutti, in un anno
storico, protagonista di un Mondiale che l’Italia
ha esaltato con la grinta e la prudenza tagliando man
mano un attaccante dietro l’altro perché l’importante
non è più giocare ma vincere difendendosi. Il calcio
pitagorico del 4-4-2, 3-4-3, 5-3-1-1, 3-4-2-1 ha ucciso
le ali, trasforma i terzini in folli corrieri, immortala
Gattuso ed esilia Baggio e Zola, com’è capitato,
costringe il centravanti a una solitudine infinita ed è
solo un calcio di corsa e di falli tattici. Ha perduto
il gusto del gioco e la bussola. Nella confusione dei
nuovi ruoli, fra mezze punte, mezze tacche, incontristi
e centrocampisti tristi, la grande scuola italiana
declina mentre si importano portieri brasiliani, il
massimo di una ricerca naif, e difensori sudamericani
quando, nei tempi felici, in quei paesi cercavamo
danzatori del gol, registi di fantasia, giocolieri
immaginifici inseguendo il sogno e lo scopo del gioco:
attaccare e segnare nella maniera più deliziosa e
sorprendente possibile.
Professorini e professoroni di Coverciano hanno imposto la
tattica, strumento di una logica inesistente in un gioco
che non è il gioco degli scacchi, ed è piuttosto la
falsa merce venduta per spillare contratti d’oro a
presidenti creduloni, così siamo alle partite tutte
uguali, ai comizi a centrocampo, al palleggio monotono
dell’ormai insopportabile possesso-palla che ha un senso
solo nel basket, e per 90 minuti non c’è lo straccio di
una invenzione sorprendente con biglietti che costano
sino a 240 euro per vedere niente. Si grida al miracolo
se il romanista Aquilani esegue una “rabona”, il mancino
colpo sotto del pibe de oro, e il centravanti di Lipari
Christian Riganò si produce in un “sombrero”, numeri che
dovrebbero essere un’attrazione costante, per 240 euro,
almeno in percentuale superiore al deplorevole “fallo da
dietro”.
In queste condizioni, non è una sorpresa che il Pallone
d’oro e il premio della Fifa abbiano eletto un
difensore a paladino del gioco nel quale, oggi, tutto si
distrugge e nulla si crea col trucco della
celebratissima “zona” che è una tattica essenzialmente
difensiva. Circostanza felice è solo la scelta di un
guaglione napoletano dal viso simpatico, ragazzo leale,
persino sex-symbol e fotomodello di spot pubblicitari.
Cannavaro è comunque il viso sorridente del calcio,
scugnizzo allegro, feroce ma corretto spazzatutto,
campionissimo nel suo ruolo. La sua concreta e
irresistibile grazia fa accettare l’incoronazione, ma
lui stesso ne è rimasto sorpreso.
A Fabio tutti i meriti e nessuna colpa se nel giardino
che fu del principe Lanza di Trabìa a Palermo non danza
più il leggiadro danese Helge Christian Bronée, lo
zingaro del calcio, finissimo palleggiatore, ma un
difensore simpatico come il boy della Loggetta, con
piede pulito ed eleganza di gambe, spedisce il pallone
alle stelle.
 Perciò
siamo tutti contenti che “palla di gomma” ce l‘abbia
fatta a scagliare il pallone nel firmamento delle stelle
del calcio e, di rimbalzo, gliene è tornato uno d’oro.
Nella città che gioca al calcio nella Galleria Umberto,
guaglioni notturni con una maglia azzurra, negli spiazzi
delle periferie, sullo stradone del Parco delle
Rimembranze, anche Fabio Cannavaro cominciò dalla
strada, sul selciato antistante lo stadio “San Paolo”.
Il pallone era già corso in famiglia da nonno Renato a
papà Pasquale, che aveva giocato in serie C e portava
Fabio con sé nei ritiri del Casale Posillipo, l’ultima
squadra in cui giocò. Dalla strada all’Italsider di
Bagnoli, a otto anni, poi Rosario Rivellino, stopper
elegante e poi allenatore e dirigente prezioso, portò
Fabio tra i “giovanissimi” del Napoli. Rivellino
assicurò Cannavaro, lo sfortunatissimo Ciro Caruso
(altro difensore di grande qualità) e Gagliotti al
Napoli in cambio di un bigliardo, sì proprio un
bigliardo, espressamente richiesto dal Cral dell’Italsider
che, per statuto, non poteva incassare soldi. Primo
grosso impegno di Fabio: raccattapalle negli anni di
Maradona. Voleva diventare Ciro Ferrara, ammirava la
grinta di Nela e stravedeva per Rudy Krol. Per diventare
un mix dei tre campioni, d’estate, a Sapri, giocava a
pallone per interminabili giornate nel camping “Europa
unita”. In tutti i sensi, un difensore venuto dal mare. Perciò
siamo tutti contenti che “palla di gomma” ce l‘abbia
fatta a scagliare il pallone nel firmamento delle stelle
del calcio e, di rimbalzo, gliene è tornato uno d’oro.
Nella città che gioca al calcio nella Galleria Umberto,
guaglioni notturni con una maglia azzurra, negli spiazzi
delle periferie, sullo stradone del Parco delle
Rimembranze, anche Fabio Cannavaro cominciò dalla
strada, sul selciato antistante lo stadio “San Paolo”.
Il pallone era già corso in famiglia da nonno Renato a
papà Pasquale, che aveva giocato in serie C e portava
Fabio con sé nei ritiri del Casale Posillipo, l’ultima
squadra in cui giocò. Dalla strada all’Italsider di
Bagnoli, a otto anni, poi Rosario Rivellino, stopper
elegante e poi allenatore e dirigente prezioso, portò
Fabio tra i “giovanissimi” del Napoli. Rivellino
assicurò Cannavaro, lo sfortunatissimo Ciro Caruso
(altro difensore di grande qualità) e Gagliotti al
Napoli in cambio di un bigliardo, sì proprio un
bigliardo, espressamente richiesto dal Cral dell’Italsider
che, per statuto, non poteva incassare soldi. Primo
grosso impegno di Fabio: raccattapalle negli anni di
Maradona. Voleva diventare Ciro Ferrara, ammirava la
grinta di Nela e stravedeva per Rudy Krol. Per diventare
un mix dei tre campioni, d’estate, a Sapri, giocava a
pallone per interminabili giornate nel camping “Europa
unita”. In tutti i sensi, un difensore venuto dal mare.
E’ stato l’ultimo prodotto d’eccellenza del vivaio del
Napoli vincendo il suo primo scudetto con la squadra
Allievi, a 14 anni, svezzato da Riccardino De Lella, uno
degli ultimi appassionati maestri dei piccoli calciatori
napoletani, vent’anni nelle giovanili azzurre. Quei
maestri sono un po’ scomparsi. Al tempo di Juliano e
Montefusco ragazzini, diciamo dagli anni ’50 ai ’60, ne
girava uno per le strade e i campetti di Napoli, un uomo
piccolo e robusto, calvo, l’abbronzatura perenne,
burbero e paterno. Si chiamava Giovanni Lambiase,
talent-scout ruspante, Diogene del pallone che cercava
con la lanterna del suo sesto senso il campione del
futuro. Prima del fiorire delle scuole-calcio, la strada
era proprio la scuola dei calciatori in erba. E, alle
giovanili del Napoli, i ragazzi trovavano un uomo buono
e generoso, che ne sorvegliava la vita, gli studi e i
progressi sul campo. Si chiamava Paolo Fino, nolano,
impiegato al Comune di Napoli, che dedicò tutta la sua
vita al vivaio azzurro, uomo di fiducia più che
dirigente, però popolarissimo ai tornei giovanili.
Accompagnava i giovani calciatori a scuola con la sua
sgangherata utilitaria e gli era sempre vicino. Molto è
cambiato. Oggi, i ragazzi sono subito attenti alle
griffe dell’abbigliamento sportivo prima ancora che al
pallone sognando anzitempo un gol e una velina.
C’è stato un buon periodo del vivaio azzurro da cui
sbocciarono i quattro moschettieri Juliano, Montefusco,
Improta e Abbondanza “il sivorino”, poi Nino Musella, il
ragazzo dalle straordinarie capacità tecniche che non
volle diventare Rivera distraendosi con troppe fughe dai
ritiri. Successivamente, allenatori di carisma come
Sormani, Canè, Rivellino, Mariolino Corso esaltarono il
vivaio napoletano. Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro sono
stati gli ultimi gioielli, Fabio ceduto troppo presto, a
22 anni, per esigenze di bilancio. Fino a poco tempo fa
si leggeva ancora su un muro della Loggetta, il suo
quartiere, la scritta: “Cannavaro non firmare”. Era già
pronto per lui il contratto del Parma.
Ferrara e Cannavaro, due difensori. Mettiamoci che nella
suggestione dei loro sogni c’era un esempio mirabile,
Peppe Bruscolotti, il guerriero azzurro di 511 partite.
Sta tornando, nel Napoli, la voglia e l’ambizione di crescere
campioni in casa. Il settore giovanile va riprendendo
quota, diretto da Giuseppe Santoro e con la supervisione
di Enzo Montefusco. Ragazzi sbocciati proprio dal
vecchio centro di Marianella, dove la “Primavera” del
Napoli vinse lo scudetto del 1979, sono i nuovi maestri,
in testa Gigi Caffarelli, l’apache del quartiere Sanità,
campione d’Italia col pibe de oro, e, tra loro, Ivan
Faustino, 37 anni, figlio del popolarissimo Canè.
Mimmo Carratelli
Nelle foto:
in alto, Fabio Cannavaro con il Pallone d'Oro durante la
premiazione a Parigi; al centro, Cannavaro (il ragazzo
con il dito alzato) raccattapalle al San Paolo, durante
i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli nel 1987; in
basso , a San Gregorio Armeno si preparano i pastori con
Cannavaro.
|
|
Beato,
masseur gentile dalle mani d'acciaio
 Una vita con il Napoli e per il Napoli,
una vita a fare massaggi con le sue mani d’acciaio, ad ascoltare
confidenze, malumori, accuse, a mediare tra dissidi di spogliatoi, a
raccogliere maldicenze, sfoghi, risentimenti. Chissà quanti segreti
ha portato con sé. Superstizioso, come
tutti i napoletani, distribuiva e suggeriva riti scaramantici negli
spogliatoi.
Una vita con il Napoli e per il Napoli,
una vita a fare massaggi con le sue mani d’acciaio, ad ascoltare
confidenze, malumori, accuse, a mediare tra dissidi di spogliatoi, a
raccogliere maldicenze, sfoghi, risentimenti. Chissà quanti segreti
ha portato con sé. Superstizioso, come
tutti i napoletani, distribuiva e suggeriva riti scaramantici negli
spogliatoi.
Severo e affettuoso insieme. Nell’elenco degli “indimentica
bili"della società azzurra non può mancare Michelangelo
Beato, massaggiatore dagli ultimi Anni Venti per quaranta stagioni.
Un'istituzione. Ha distribuito scampoli di cronaca, di aneddoti, oltre che caramelle
al miele agli amici, ai ragazzini e ai giovani giornalisti. Non
aveva peli sulla lingua e per questo è stato amato e temuto..
 Raccontano che fu molto legato ad Ascarelli e Garbutt. Sotto la loro
guida era avvenuta, tra l’altro, la sua successione al massaggiatore
in primis, De Palma. Prima di quell’incarico, Beato era
diventato popolare girando la domenica all’ Ascarelli, intorno al
campo con un grande cartello recante il nome dell’arbitro designato,
ed era l’unica informazione che i giornali non riportavano ancora e
non si era fatto in tempo a stampare sui “programmi” della partita
distribuiti allo stadio.
In giro a braccia alzate, un po’ come le belle ragazze che
annunciano la sequenza dei round sul ring di boxe.
Raccontano che fu molto legato ad Ascarelli e Garbutt. Sotto la loro
guida era avvenuta, tra l’altro, la sua successione al massaggiatore
in primis, De Palma. Prima di quell’incarico, Beato era
diventato popolare girando la domenica all’ Ascarelli, intorno al
campo con un grande cartello recante il nome dell’arbitro designato,
ed era l’unica informazione che i giornali non riportavano ancora e
non si era fatto in tempo a stampare sui “programmi” della partita
distribuiti allo stadio.
In giro a braccia alzate, un po’ come le belle ragazze che
annunciano la sequenza dei round sul ring di boxe.
Con mister Garbutt ,
l’attento e fido Michelangelo, anche in base ai suoi particolari
punti di vista, collaborò pure nei servizi di “ronda” negli
alberghi per evitare (non tanto per segnalare) inopportuni incontri
tra giocatori e disponibili signorine.
I maligni rivelarono le sue tendenze poco maschie, nonostante
la forza dei suoi bicipiti. E sul campo, nel completo anonimato,
qualcuno osò anche sfotticchiarlo, per i suoi modi…gentili. Il
compianto, valoroso, attento giornalista de "Il Mattino", Mario Vitelli
raccontava che una volta allo stadio del Vomero un tifoso dagli spalti
gli gridò più volte durante un allenamento tra gli azzurri :
“Nanninè, chi è chillu centravant?”.
 E Beato, stanco delle
insinuazioni insolenti e alquanto risentito, girandosi verso le
tribune, rispose con calma e determinazione al tifoso anonimo: “Chillu
centravanti è Sartori.
E nanninella è chella stuppola ‘e soreta”.
Personaggio dalla battuta sferzante, collaboratore e amico di tutti
negli spogliatoi, tranne che per i falsi e gli antipatici, tra cui
annoverò l’allenatore Amadei, accusato di servilismo nei confronti
del Comandante Lauro (che frequentemente riceveva a rapporto il tecnico del
Napoli seminudo sul suo terrazzo, al mattino all’ora di colazione,
mentre faceva le flessioni in costume adamitico e
mangiava frutta sotto lo
sguardo involontario e scandalizzato delle suore del palazzo di
fronte). Così quando l’attaccante Manuel Del Vecchio, dopo uno
sgarbo, aggredì Amadei negli spogliatoi, Beato accorse tra i primi,
dando l’impressione che volesse dividere i contendenti, ma in
effetti tenne stretto l’allenatore finchè Del Vecchio non mise a
segno un bel pugno. Poi con grande gaudio andò a premere il
batuffolo intriso d’alcol sulla parte lacero contusa dell’antipatico
mister Amadei, accompagnando il gesto con una
strizzatina d'occhio. E Beato, stanco delle
insinuazioni insolenti e alquanto risentito, girandosi verso le
tribune, rispose con calma e determinazione al tifoso anonimo: “Chillu
centravanti è Sartori.
E nanninella è chella stuppola ‘e soreta”.
Personaggio dalla battuta sferzante, collaboratore e amico di tutti
negli spogliatoi, tranne che per i falsi e gli antipatici, tra cui
annoverò l’allenatore Amadei, accusato di servilismo nei confronti
del Comandante Lauro (che frequentemente riceveva a rapporto il tecnico del
Napoli seminudo sul suo terrazzo, al mattino all’ora di colazione,
mentre faceva le flessioni in costume adamitico e
mangiava frutta sotto lo
sguardo involontario e scandalizzato delle suore del palazzo di
fronte). Così quando l’attaccante Manuel Del Vecchio, dopo uno
sgarbo, aggredì Amadei negli spogliatoi, Beato accorse tra i primi,
dando l’impressione che volesse dividere i contendenti, ma in
effetti tenne stretto l’allenatore finchè Del Vecchio non mise a
segno un bel pugno. Poi con grande gaudio andò a premere il
batuffolo intriso d’alcol sulla parte lacero contusa dell’antipatico
mister Amadei, accompagnando il gesto con una
strizzatina d'occhio.
Con la sua lunga militanza in azzurro, il suo ruolo confidenziale
con i giocatori, i contatti con i dirigenti e la Stampa, Beato
avrebbe potuto scrivere la più gustosa e documentata storia del
Napoli. Anche da pensionato, infatti, continuò a frequentare gli
spogliatoi del San Paolo. Ma improvvisamente il filo si spezzò con
la sua tragica morte. Fu investito da un camion in retromarcia al
Vomero.
Nelle foto, in alto a sinistra Michelangelo Beato
giovanissimo nel Napoli di Garbutt (alle sue spalle c'è Vojak con il
suo solito basco); a destra
Beato massaggiatore negli Anni Settanta; infine, Beato con il
presidente Roberto Fiore nel campionato 1964-65.
|
|

